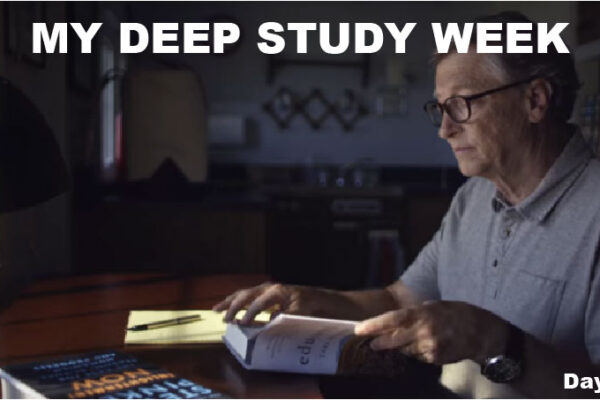Alcuni giorni fa ho pubblicato un articolo su OIR, AIR ed EIR – i tre pilastri della gestione informativa secondo la ISO 19650. Le reazioni sono state interessanti, ma soprattutto mi hanno fatto capire una cosa: molti di voi vorrebbero approfondire quella prima immagine della gerarchia dei requisiti informativi presente nella norma ISO 19650-1. Quella figura apparentemente semplice che mostra come tutti i pezzi del puzzle si incastrano tra loro.
E così eccomi qui, con questo primo articolo di una serie che cercherà di spiegare meglio non solo gli strumenti, ma soprattutto le relazioni che li legano. Perché, credetemi, ti è mai capitato di trovarti davanti a un progetto BIM e chiederti: “Ma chi ha deciso che servivano proprio queste informazioni? E perché proprio in questo formato?” Se la risposta è sì, allora questo viaggio fa per te. Perché dietro ogni modello informativo che si rispetti c’è una storia, una logica, una vera e propria genealogia che affonda le radici nella strategia dell’organizzazione e arriva fino ai dettagli più tecnici del progetto.
La norma UNI EN ISO 19650-1 non è solo un documento tecnico – è una mappa del tesoro che ci guida attraverso il mondo complesso dei requisiti informativi. E come ogni mappa che si rispetti, ha i suoi simboli, le sue convenzioni e soprattutto le sue relazioni. Oggi parleremo proprio di queste relazioni, di quei “racchiude”, “contribuisce a” e “specifica” che spesso vengono liquidati con un’occhiata distratta ma che invece sono il cuore pulsante di tutto il sistema.
Il Grande Disegno: Dalla Visione all’Azione
Immagina la gestione delle informazioni come un grande albero genealogico, dove ogni generazione passa il testimone alla successiva, arricchendolo e specificandolo. Al vertice di questa piramide ci sono gli Organizational Information Requirements (OIR) – i requisiti informativi dell’organizzazione. Non sono solo una lista della spesa di dati desiderati, ma rappresentano la traduzione digitale della visione strategica di un’azienda, di un ente pubblico, di qualsiasi organizzazione che gestisce patrimoni immobiliari.
Gli OIR “racchiudono” – e qui usiamo il termine nella sua accezione più profonda – tutto ciò che l’organizzazione considera strategicamente rilevante. Quando un ospedale definisce i propri OIR, non sta semplicemente elencando che tipo di informazioni vuole sui propri edifici. Sta traducendo in linguaggio digitale la propria missione: curare i pazienti nel modo più efficace possibile. Ogni requisito informativo diventa così un tassello di questa missione più grande.
Ma attenzione: “racchiudere” non significa semplicemente “contenere”. È un verbo dinamico, che implica una responsabilità. Gli OIR racchiudono le aspettative, le responsabilità, i criteri di successo dell’intera organizzazione. Sono il DNA informativo che si trasmetterà a tutte le generazioni successive di requisiti.
L’Arte del “Contribuisce a”: Quando i Patrimoni Parlano
Scendiamo di un gradino e incontriamo gli Asset Information Requirements (AIR) – i requisiti informativi del patrimonio esistente. Qui entra in gioco la prima relazione fondamentale: gli AIR “contribuiscono a” definire gli OIR. Non è una questione di semplice dipendenza gerarchica, ma di dialogo continuo tra presente e futuro, tra ciò che esiste e ciò che si vuole diventare.
Facciamo un esempio concreto. Un’università ha negli OIR l’obiettivo di “ottimizzare l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare per ridurre del 30% i consumi entro il 2030”. Gli AIR degli edifici esistenti non si limitano a elencare i consumi attuali. Contribuiscono attivamente a questo obiettivo identificando quali informazioni sui sistemi impiantistici, sulle prestazioni degli involucri, sui pattern di utilizzo degli spazi sono necessarie per raggiungere quel traguardo.
Il “contribuisce a” è quindi una relazione di servizio intelligente. Gli AIR non sono passivi contenitori di dati sul patrimonio esistente – sono consulenti esperti che, conoscendo intimamente le caratteristiche e le potenzialità degli asset, suggeriscono all’organizzazione come orientare le proprie strategie informative.
Ma c’è di più. Gli AIR “racchiudono” a loro volta tutto ciò che il patrimonio esistente può raccontare di sé stesso. E lo fanno attraverso quattro grandi famiglie di informazioni, come ci ricorda la ISO 19650-3: informazioni tecniche (le caratteristiche prestazionali, le interdipendenze, i dati di commissioning), informazioni legali (proprietà, responsabilità manutentive, obblighi normativi), informazioni commerciali (fornitori, criticità, KPI Key Performance Indicators), e informazioni finanziarie (costi di gestione, valori di rimpiazzo, impatto dei fermi).

Il Ponte tra Strategia e Progetto: I PIR
Ed ecco che arriviamo ai Project Information Requirements (PIR), forse gli elementi più incompresi dell’intera gerarchia. I PIR “contribuiscono a” definire sia gli OIR che gli AIR, ma con una particolarità: rappresentano il punto di incontro tra il mondo della strategia e quello dell’operatività progettuale.
Immagina i PIR come un traduttore simultaneo durante una conferenza internazionale. Da una parte ci sono gli OIR che parlano il linguaggio della strategia aziendale (“vogliamo migliorare l’efficienza operativa”), dall’altra ci sono le esigenze concrete del progetto (“stiamo ristrutturando il padiglione nord dell’ospedale”). I PIR traducono questi due linguaggi in una sintesi operativa: “per questo specifico progetto di ristrutturazione, abbiamo bisogno di informazioni che ci permettano di monitorare l’efficienza operativa del padiglione nord nel contesto più ampio della strategia ospedaliera”.
Il “contribuisce a” dei PIR è quindi bidirezionale. Contribuiscono a precisare gli OIR contestualizzandoli sul progetto specifico, e contemporaneamente contribuiscono a informare gli AIR su come il nuovo intervento si integrerà con il patrimonio esistente.
La Traduzione Operativa: Gli EIR e il “Specifica”
Arriviamo ora al cuore operativo del sistema: gli Exchange Information Requirements (EIR), i requisiti di scambio delle informazioni. Qui la relazione dominante cambia natura. Gli EIR non “racchiudono” né “contribuiscono a” – gli EIR “specificano”. E questa differenza terminologica non è casuale.
“Specificare” significa trasformare l’astratto in concreto, il desiderio in istruzione operativa. Gli EIR prendono tutto il lavoro svolto a monte – OIR, AIR, PIR – e lo traducono nel linguaggio che i progettisti, i fornitori, i consulenti possono effettivamente comprendere e implementare.
Facciamo un esempio pratico. Gli OIR di un’azienda farmaceutica includono “garantire la tracciabilità completa dei processi produttivi per conformità normativa”. Gli AIR del stabilimento esistente contribuiscono identificando “necessità di integrare i nuovi sistemi con il sistema di gestione qualità esistente”. I PIR del progetto di ampliamento contribuiscono precisando “per il nuovo laboratorio R&D, servono informazioni che permettano audit normativi”. Gli EIR specificano: “il modello informativo del nuovo laboratorio deve includere, per ogni ambiente, la codifica conforme al sistema aziendale XYZ, l’indicazione dei flussi di processo secondo lo standard ABC, e la documentazione degli impianti critici nel formato DEF”.
Vedi la differenza? Gli EIR non si limitano a dire cosa serve – dicono esattamente come deve essere fatto, in quale formato, secondo quali standard, con quale livello di dettaglio. Sono il ponte tra il mondo delle intenzioni e quello dell’esecuzione.
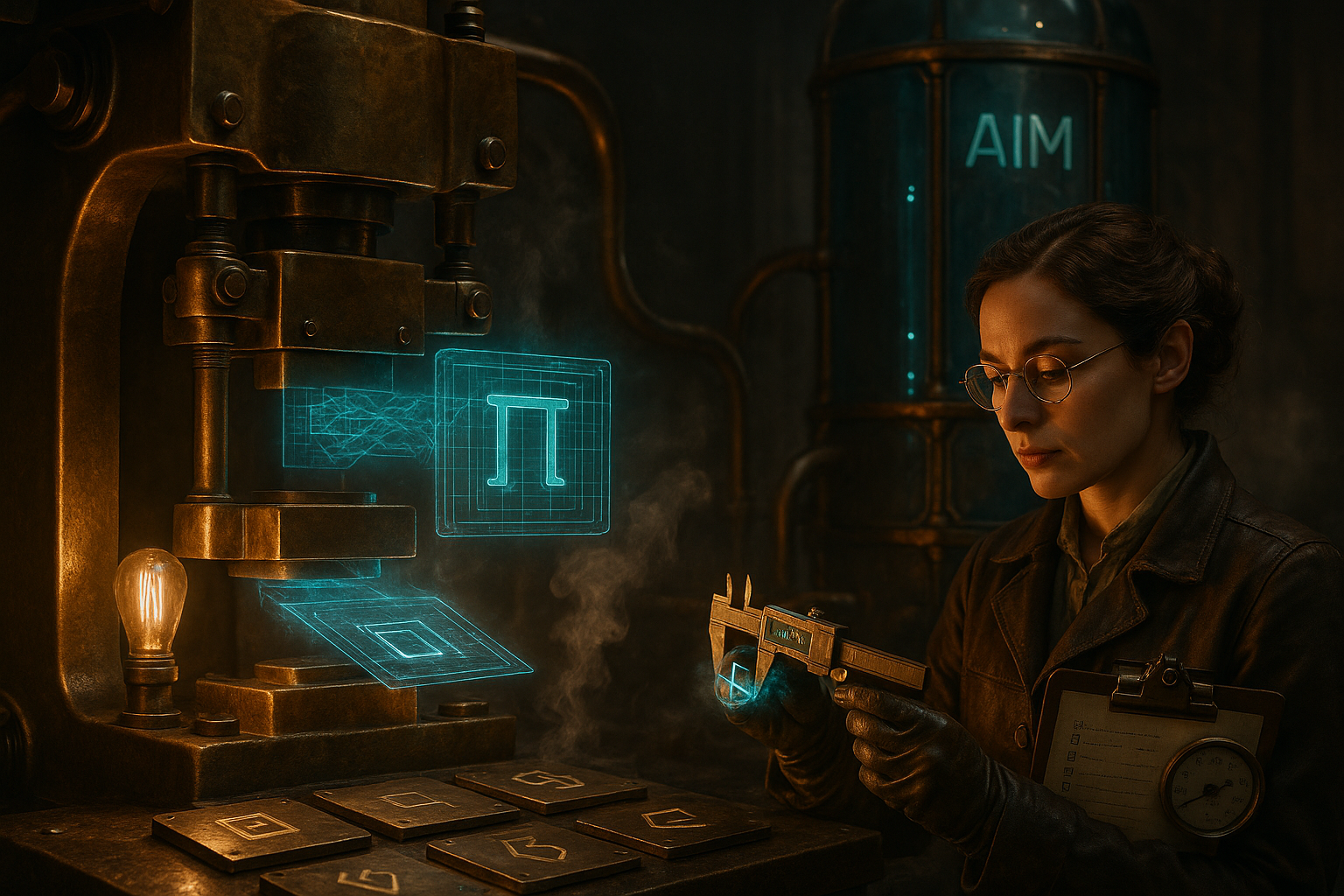
Il Ciclo si Chiude: PIM e AIM
Il viaggio attraverso la gerarchia si conclude con i modelli informativi veri e propri: il Project Information Model (PIM) e l’Asset Information Model (AIM). Ma attenzione, non si tratta di un punto di arrivo – è piuttosto un nuovo punto di partenza.
Il PIM “specifica” tutto ciò che è stato richiesto dagli EIR, dandogli forma concreta nel mondo digitale. Ma la sua vita è temporanea, legata alla durata del progetto. Una volta completato il progetto, le informazioni rilevanti del PIM migrano verso l’AIM, che “racchiude” tutto ciò che serve per la gestione operativa dell’asset.
E qui si chiude il cerchio. L’AIM, arricchito dalle informazioni del progetto appena completato, andrà a modificare gli AIR futuri. Le nuove conoscenze acquisite, le performance misurate, le lezioni apprese diventeranno input per ridefinire sia gli AIR di quell’asset specifico, sia potenzialmente gli OIR dell’intera organizzazione.
I Tre Percorsi della Norma
La ISO 19650-1 non è dogmatica. Riconosce che nella realtà esistono tre scenari diversi, tre percorsi possibili attraverso questa gerarchia:
Il percorso “solo progettazione” (PIR-EIR-PIM): quando un’organizzazione commissiona un progetto senza preoccuparsi particolarmente della gestione operativa futura. È il caso classico del developer che realizza per vendere.
Il percorso “solo gestione” (OIR-AIR-AIM): quando un’organizzazione si concentra sulla gestione del patrimonio esistente senza nuovi progetti in vista. È il caso del gestore patrimoniale che ottimizza l’esistente.
Il percorso “integrato” (OIR-AIR-EIR-PIM-AIM e PIR-EIR-PIM-AIM): quando progettazione e gestione operativa sono viste come un continuum. È l’approccio più maturo e complesso, ma anche quello che garantisce i maggiori benefici nel lungo termine.
Oltre la Tecnica: Un Cambio di Mentalità
Quello che spesso si perde, quando si parla di ISO 19650, è che non stiamo parlando solo di una questione tecnica. Stiamo parlando di un cambio di mentalità profondo. La gerarchia dei requisiti informativi ci costringe a pensare in termini di relazioni, di flussi, di trasformazioni continue dell’informazione.
Ogni “racchiude”, “contribuisce a” e “specifica” non è solo una relazione logica – è un passaggio di responsabilità, un momento di trasformazione dell’informazione, un’opportunità per aggiungere valore e intelligenza al processo.
Quando un progettista riceve gli EIR, non sta semplicemente ricevendo una lista di requisiti. Sta ricevendo il distillato di un processo di riflessione strategica che parte dalla visione dell’organizzazione, passa attraverso la conoscenza del patrimonio esistente, si confronta con le esigenze del progetto specifico, e arriva fino a lui sotto forma di istruzioni operative concrete.
La prossima volta che ti trovi davanti a un capitolato informativo, prova a ricostruire questo percorso. Chiediti: qual era la visione strategica di partenza? Come hanno contribuito le caratteristiche del patrimonio esistente? Quali esigenze specifiche del progetto hanno influenzato le richieste? Solo così potrai comprendere veramente non solo il “cosa” fare, ma soprattutto il “perché” farlo.
Perché alla fine, la vera rivoluzione del BIM non è tecnologica – è culturale. È imparare a vedere ogni informazione non come un dato isolato, ma come un tassello di un mosaico più grande, dove ogni pezzo ha senso solo in relazione a tutti gli altri.