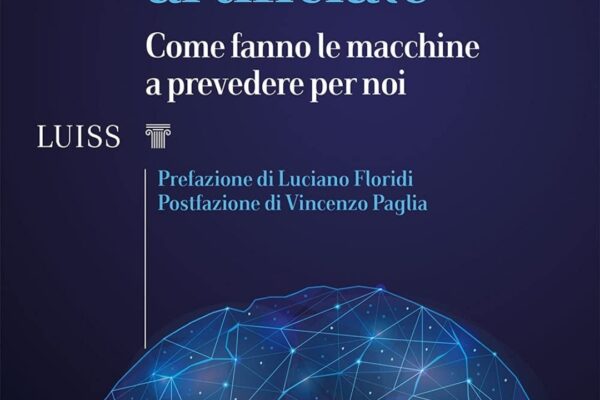Prima di pensare a qualsiasi modello BIM, la tua organizzazione deve guardarsi allo specchio e chiedersi “Chi sono? Cosa voglio davvero dai miei edifici?”. È come fare un test del DNA aziendale… solo che invece dei cromosomi, cerchiamo i dati che faranno la differenza tra il successo e l’ennesimo progetto “bello ma inutile”.
Era il 2019 quando iniziai a capire che il Building Information Modeling non era solo una questione di software e coordinate geometriche. Il vero game-changer stava in un documento dall’acronimo apparentemente innocuo: OIR – Organizational Information Requirements. I Requisiti Informativi dell’Organizzazione secondo la ISO 19650-1, clausola 5.2. Un documento che, secondo la norma, dovrebbe tradurre gli obiettivi strategici di alto livello in fabbisogni informativi concreti e attuabili.
Ma cosa significa davvero nella pratica quotidiana di chi commissiona un ospedale, un’università o un grattacielo? Ecco quello che ho imparato dai miei anni sul campo.
Il DNA Digitale della Tua Organizzazione
Immagina di essere il direttore generale dell’Università Tecnica della Toscana – proprio come la Prof.ssa Elena Marchetti del nostro caso studio “Città del Futuro”. Hai 45 edifici distribuiti in 3 campus, 3.000 studenti in arrivo nel nuovo campus sostenibile, e un budget di 120 milioni di euro. La domanda non è “che tipo di modelli BIM vogliamo?” ma piuttosto “quali informazioni ci servono per prendere decisioni strategiche nei prossimi 10 anni?”
L’OIR è esattamente questo: il momento in cui l’organizzazione si ferma, riflette sulla propria missione, e traduce visione e obiettivi a lungo termine in esigenze informative tangibili. Non è un documento per il singolo progetto – quello sarà il Project Information Requirements (PIR) – ma la bussola strategica che guiderà tutti i progetti futuri.
La bellezza dell’approccio ISO 19650 sta proprio in questa gerarchia top-down: tutto parte dall’OIR. Come una cascata digitale, i Requisiti Informativi dell’Organizzazione alimentano gli Asset Information Requirements (AIR), che a loro volta generano i PIR, fino ad arrivare agli Exchange Information Requirements (EIR) – il documento operativo che finalmente dice ai progettisti “ecco cosa dovete consegnarmi, e in che formato”.

Quando l’Ospedale Incontra l’Università: OIR a Confronto
Permettimi di raccontarti due storie parallele che illustrano perfettamente come organizzazioni diverse abbiano esigenze informative completamente differenti.
Scenario 1: Ospedale Regionale “San Marco”
Il direttore sanitario ha obiettivi chiari: ridurre i tempi di permanenza dei pazienti del 15% entro il 2027, ottimizzare i flussi di emergenza, e dimostrare compliance normativa per l’accreditamento regionale. L’OIR dell’ospedale si concentrerà quindi su:
- Tracciabilità dei percorsi di cura (da quale stanza il paziente arriva in chirurgia?)
- Gestione delle emergenze (dove sono gli accessi più rapidi alle sale operatorie?)
- Manutenzione predittiva delle apparecchiature critiche (quando il TAC avrà bisogno della prossima manutenzione?)
- Controllo ambientale (temperatura, umidità, pressurizzazione delle sale sterili)
Scenario 2: Università Tecnica della Toscana
La Prof.ssa Marchetti ha invece obiettivi legati all’eccellenza formativa: attrarre i migliori docenti europei, garantire spazi di studio flessibili per metodologie didattiche innovative, raggiungere la certificazione LEED Platinum per attrarre finanziamenti sostenibili. L’OIR dell’università punterà su:
- Flessibilità degli spazi (questa aula può essere riconfigurata per il lavoro in gruppo?)
- Prestazioni energetiche (stiamo rispettando i target di sostenibilità?)
- Utilizzo degli spazi (quali laboratori sono sottoutilizzati?)
- Integrazione tecnologica (la fibra ottica raggiunge tutti gli edifici del campus?)
Vedi la differenza? Stessi principi ISO 19650, obiettivi completamente diversi, OIR radicalmente differenti.

Il Collegamento con i KPI: Dai Sogni ai Numeri
Qui sta il vero trucco dell’OIR ben fatto: ogni requisito informativo deve essere tracciabile fino a un Key Performance Indicator aziendale misurabile. Non basta dire “vogliamo una gestione efficiente dell’energia” – bisogna specificare “vogliamo ridurre i consumi energetici del 20% entro il 2028, con target intermedi di -8% annuale”.
Nel caso del Campus “Città del Futuro”, l’università ha definito KPI precisi:
- Efficienza energetica: < 15 kWh/m²/anno (target NZEB)
- Tasso di occupazione aule: > 85% nelle ore di punta
- Tempo medio di risposta manutenzione: < 4 ore per guasti critici
- Soddisfazione studenti: > 4.5/5 nei questionari di valutazione spazi
Ogni KPI genera requisiti informativi specifici. Per monitorare l’efficienza energetica, avrò bisogno di sensori IoT, sistemi di Building Automation integrati, e dashboard real-time. Per ottimizzare l’occupazione delle aule, mi serviranno sensori di presenza, sistemi di prenotazione intelligenti, e analisi predittive sui pattern di utilizzo.
L’Arte dell’OIR Strutturato: Dal Vago al Verificabile
Uno degli errori più comuni in cui ci si imbatte è confondere gli OIR con una lista di buoni propositi. “Vogliamo una manutenzione efficiente” non è un requisito informativo – è un desiderio. Un OIR strutturato secondo le migliori pratiche specifica invece:
Per ogni asset manutenzibile del tipo ‘Impianto HVAC’, popolare le seguenti proprietà nell’Asset Information Model:
- CodiceManutenzioneMTV (testo, formato MTVxxxx)
- FrequenzaManutenzioneMesi (numero intero, range 1-60)
- DataUltimaManutenzione (formato DD/MM/YYYY)
- CostoManutenzioneProgrammataEuro (numero decimale, 2 cifre)
Questa precisione non è pedanteria – è la differenza tra un AIM (Asset Information Model) utilizzabile e un archivio digitale inutile. Requisiti strutturati permettono controlli automatici, riducono gli errori, e garantiscono che l’informazione sia immediatamente utilizzabile dai sistemi di gestione del committente.
Il Rapporto con gli Standard Esistenti: l’OIR Non È un’Isola
Una delle osservazioni più interessanti che emerge dall’analisi di casi reali è come l’OIR si interfacci naturalmente con sistemi di gestione già esistenti nell’organizzazione. L’Università della Toscana, per esempio, aveva già implementato:
- Sistema di Qualità ISO 9001:2015 per i processi formativi
- Asset Management ISO 55000 per il patrimonio immobiliare
- Environmental Management ISO 14001 per gli obiettivi di sostenibilità
L’OIR non sostituisce questi sistemi – li alimenta con informazioni strutturate provenienti dai modelli BIM. È il ponte tra la strategia aziendale (già definita) e l’implementazione digitale (da costruire). Una sorta di “traduttore” che prende obiettivi come “miglioramento continuo della soddisfazione del cliente” (tipico ISO 9001) e li trasforma in “tempo medio di risoluzione guasti climatizzazione < 2 ore durante il periodo didattico”.
Le Lezioni dal Campo: Quello che i Manuali Non Ti Dicono
Dopo aver visto e discusso con colleghi di OIR in contesti diversi, ho imparato alcune lezioni che difficilmente trovi nei manuali ufficiali.
Lezione 1: Il Paradosso della Committenza
La ISO 19650 attribuisce chiaramente la responsabilità dell’OIR al committente (Appointing Party). Ha senso – solo l’organizzazione conosce i propri obiettivi strategici. Il problema? La maggior parte dei committenti, pur essendo esperti nel proprio business, non ha le competenze per tradurre strategie aziendali in requisiti informativi strutturati. È come chiedere a un grande chef di programmare in Python – magari sa cucinare divinamente, ma il codice è un altro mestiere.
Lezione 2: Il Timing È Tutto
L’OIR deve essere il primo documento del processo, non l’ultimo. Molte volte capita di vedere organizzazioni che iniziano col progetto, si accorgono di aver bisogno di dati strutturati, e solo alla fine tentano di scrivere l’OIR per “giustificare” quello che hanno già fatto. È come decidere la destinazione del viaggio dopo essere già partiti.
Lezione 3: L’OIR Vive e Si Evolve
Un OIR non è una tavola di pietra – è un documento vivente che si raffina con l’esperienza. L’Università della Toscana, per esempio, ha già pianificato una revisione dell’OIR ogni 24 mesi, incorporando i learning dai primi progetti pilota.
I Prossimi Passi: Da Domani, Cosa Puoi Fare?
Se sei arrivato fin qui, probabilmente ti stai chiedendo: “Ok, ho capito il concetto. Ma da dove comincio concretamente?”
Step 1: L’Audit degli Obiettivi
Raccogli tutti i documenti strategici della tua organizzazione degli ultimi 3 anni: piani industriali, budget, report di sostenibilità, piani di manutenzione. Identifica 5-7 obiettivi ricorrenti che potrebbero beneficiare di informazioni strutturate provenienti dal patrimonio immobiliare.
Step 2: Il Workshop degli Stakeholder
Organizza una mattinata di lavoro con i key decision maker: direttore generale, facility manager, responsabile IT, responsabile sostenibilità. Usa la tecnica dei “5 perché” per ogni obiettivo strategico, fino ad arrivare alle informazioni concrete che servirebbero per misurarne il successo.
Step 3: Il Prototipo di OIR
Non iniziare con un documento di 50 pagine. Scrivi 2-3 pagine che descrivano 1-2 obiettivi strategici prioritari e i relativi requisiti informativi. Testalo su un progetto pilota piccolo e non critico.
Step 4: La Partnership Strategica
Identifica un consulente BIM che capisca davvero il business (non solo la geometria). L’OIR è troppo importante per essere improvvisato – meglio investire nelle competenze giuste fin dall’inizio.
Il Futuro È Negli OIR Ben Fatti
Stiamo vivendo un momento unico nel settore AEC: per la prima volta, abbiamo standard internazionali (ISO 19650), tecnologie mature (BIM, IoT, AI), e una generazione di committenti che inizia a capire il potenziale strategico dei dati strutturati.
L’OIR è la chiave di volta di questo cambiamento. Non è un documento burocratico da compilare per fare felice il consulente BIM – è lo strumento che trasforma il BIM da “CAD tridimensionale” a “sistema nervoso digitale” dell’organizzazione.
Il Campus “Città del Futuro” dell’Università della Toscana, con i suoi 120 milioni di budget e i suoi obiettivi ambiziosi, sarà un test importante per verificare se questo approccio funziona davvero su scala reale. Tra tre anni sapremo se l’OIR della Prof.ssa Marchetti è riuscito a tradurre la visione strategica dell’ateneo in un campus che davvero “parla” attraverso i suoi dati.
Nel frattempo, una cosa è certa: le organizzazioni che iniziano oggi a ragionare in termini di OIR ben strutturati avranno un vantaggio competitivo significativo su chi continua a trattare il BIM come un mero strumento di progettazione.
L’organizzazione ha iniziato a parlare di sé. La domanda è: stai ascoltando